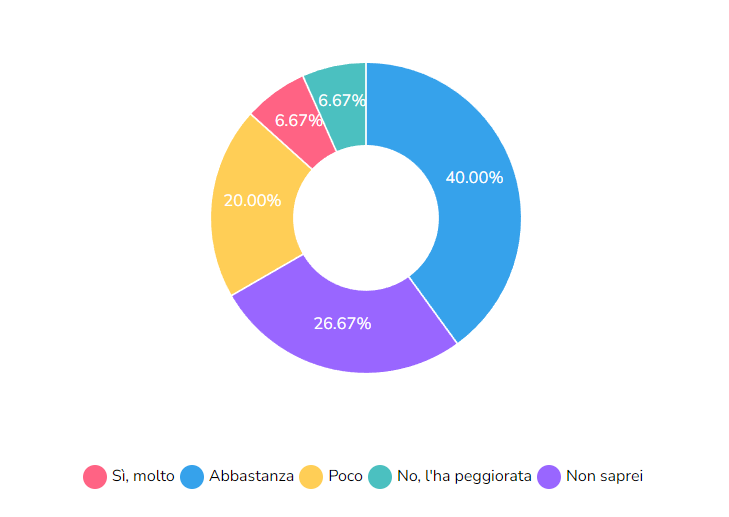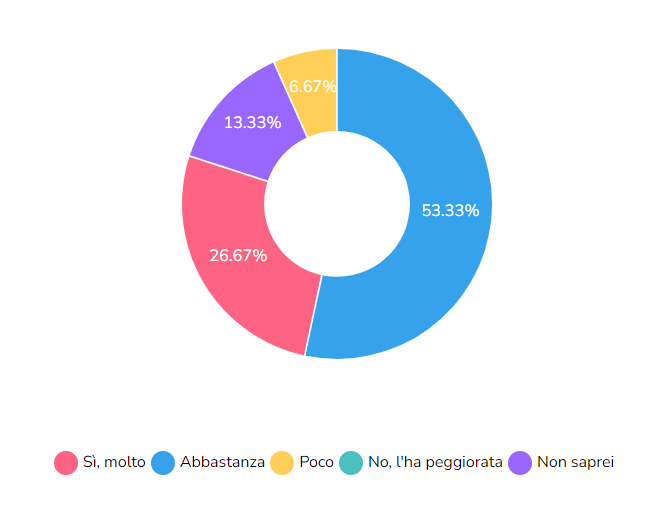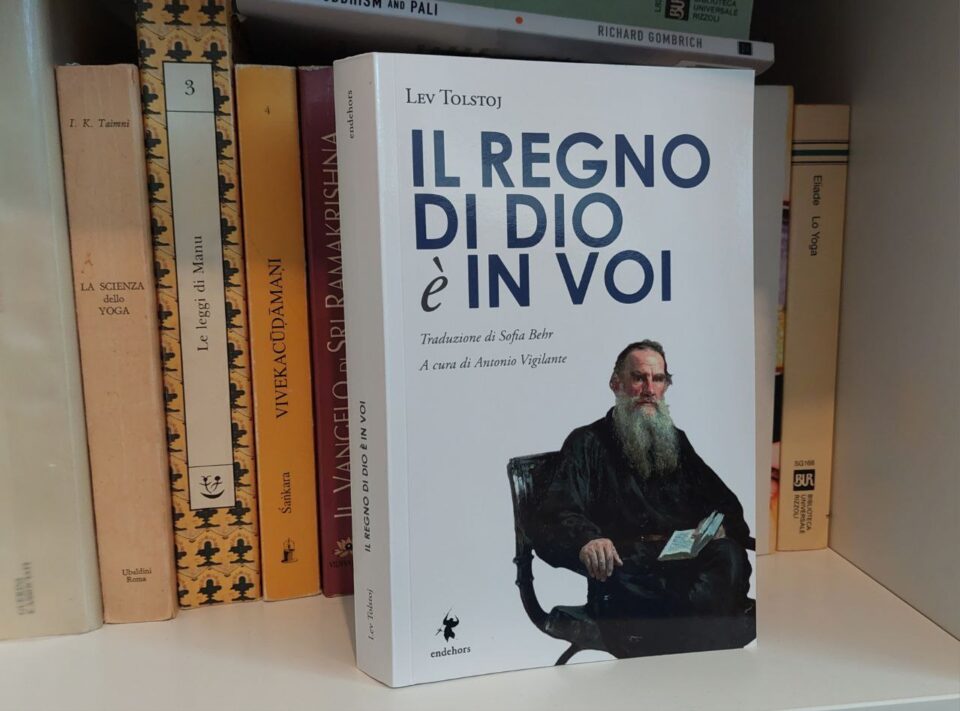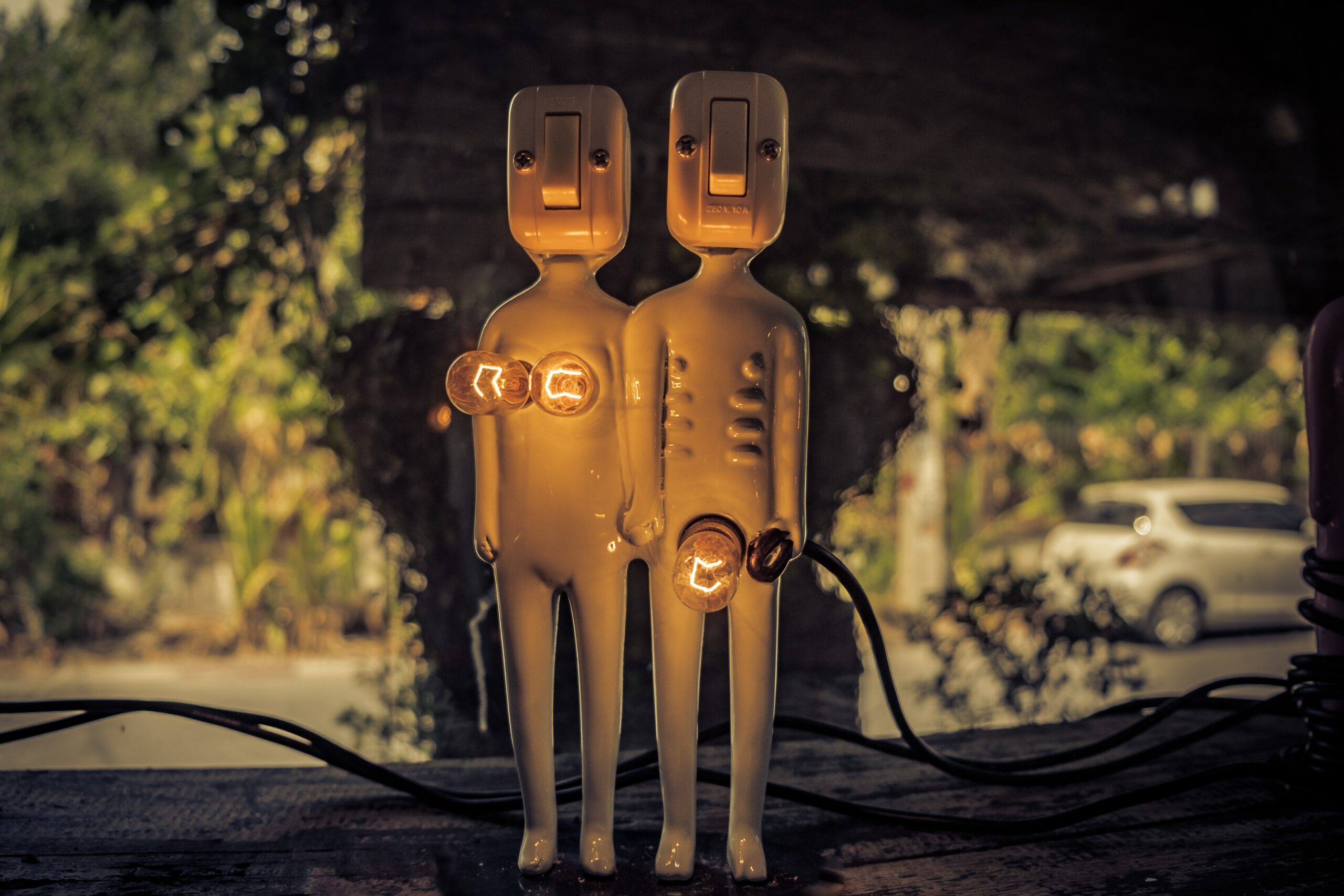Non vogliamo essere felici. Vogliamo stare in una storia: individuale, collettiva, cosmica.
Nulla disgusterebbe più di un romanzo i cui protagonisti fossero, dall’inizio alla fine, felici; e così la nostra vita. La felicità arriverà alla fine, dopo mille avventure; e allora il romanzo cesserà. Terminata la storia, i personaggi escono di scena. Se li si riporta in scena, occorre che accadano altre avventure: nell’Odissea di Nikos Kazantzakis Odisseo dovrà rimettersi in viaggio per non morire di noia accanto a Penelope. Vogliamo una storia. La felicità iniziale, poi la caduta, mille sofferenze, l’esilio, la lotta, la conquista, e poi ancora la perdita, e ancora la lotta, e la speranza, e la riconquista, e la vittoria finale, che sarà domani, non oggi – e un domani che non arriva — non deve arrivare mai.
Religione è ridurre il cosmo intero ad una narrazione, sottoporre tutto al potere di una storia. Bereshit è la parola che apre la prospettiva di senso della religione, che è sempre una prospettiva narrativa. E poiché all’altro capo c’è la liberazione finale, ogni religione è minacciata dal non senso: perché non c’è nulla che spaventi di più di una felicità priva di storia. Il Paradiso è anche peggio della morte. Il Paradiso è la dimensione nella quale appare il non senso di Dio stesso, in cui riaffiora la domanda che in realtà nemmeno la storia può tacitare: perché? Ecco, ora siamo ricondotti a Dio, ora siamo con Dio leholam. Ma: perché? Perché è Dio e non piuttosto il nulla? Cos’è questo Dio di diverso dall’essere stesso, da questo enigma per sfuggire al quale ci gettiamo nella storia?
La nostra visione del mondo è, oggi, astorica. Il cosmo che ci mostra la scienza non è riducibile a nessuna narrazione. Di qui l’importanza delle filosofie che fin dall’antichità hanno indicato la via di abitare il mondo, piuttosto che ridurlo a una narrazione: le filosofie ellenistiche, Lucrezio, Spinoza ecc. Ma sono filosofie della felicità: e noi non vogliamo essere felici.

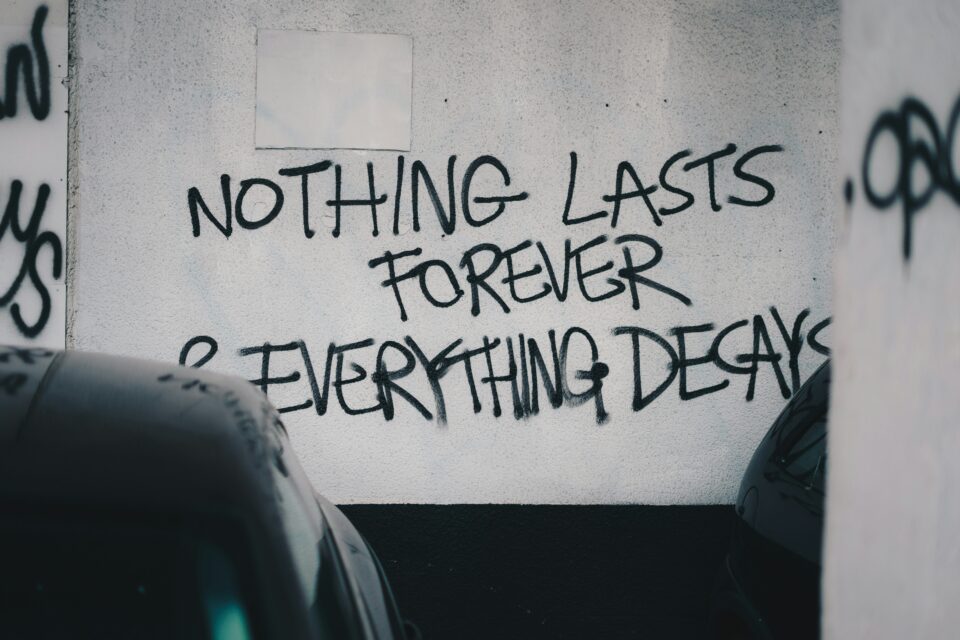
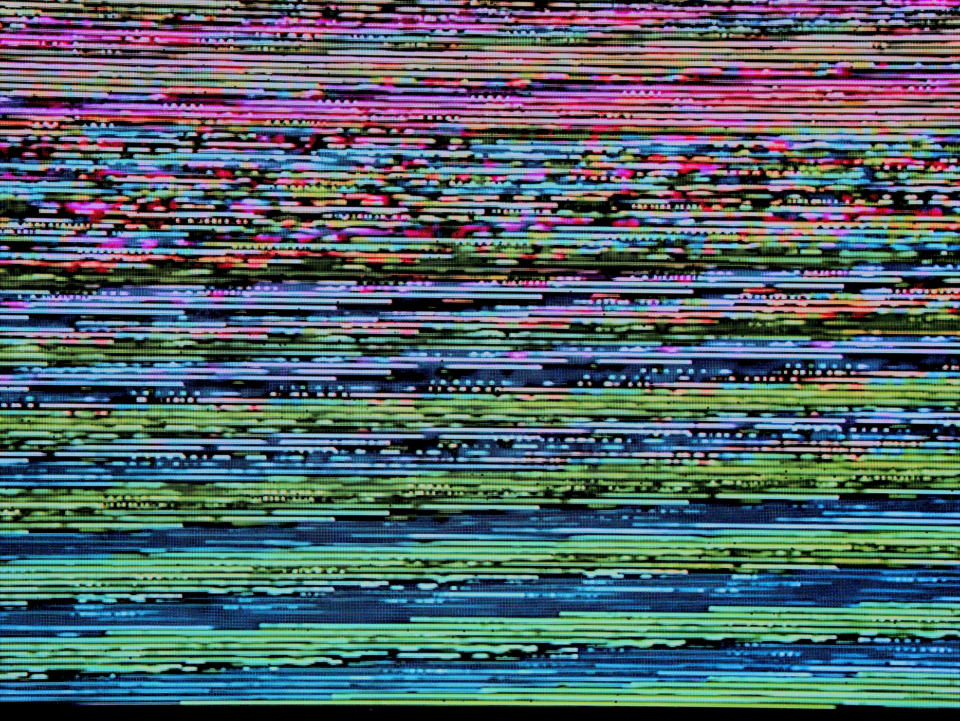
 Valeria Di Napoli, aka Pulsatilla, ha avviato un blog su Substack, Regina di Spade, in cui tenta tra l’altro una narrazione diversa dei rapporti di genere. L’
Valeria Di Napoli, aka Pulsatilla, ha avviato un blog su Substack, Regina di Spade, in cui tenta tra l’altro una narrazione diversa dei rapporti di genere. L’