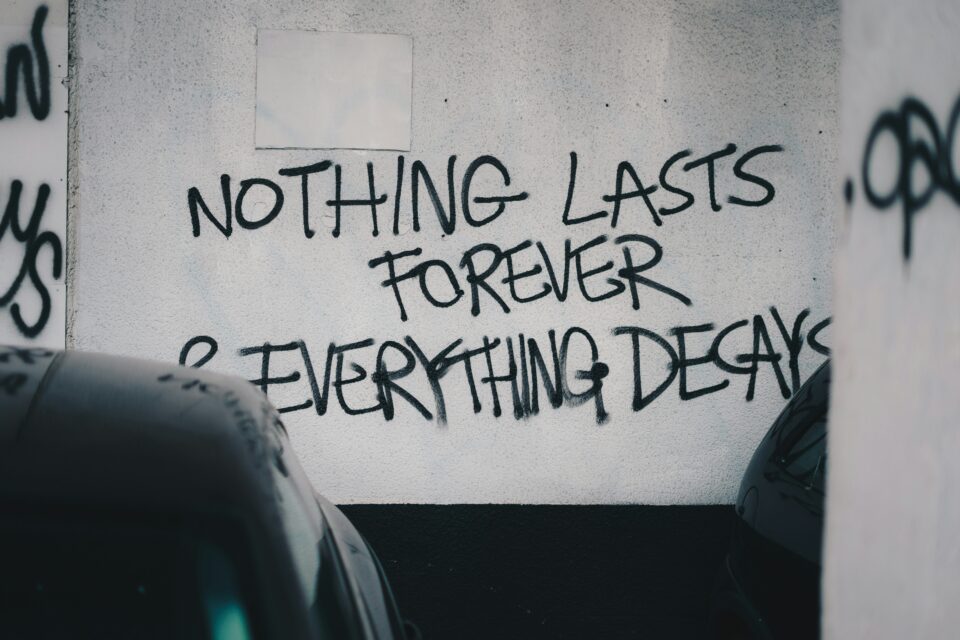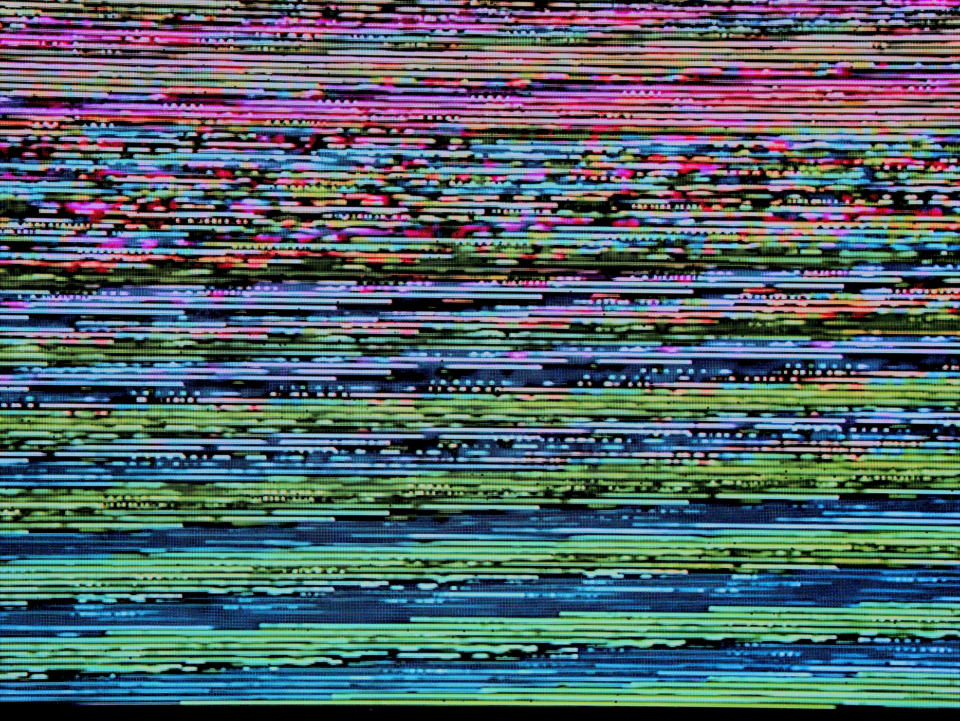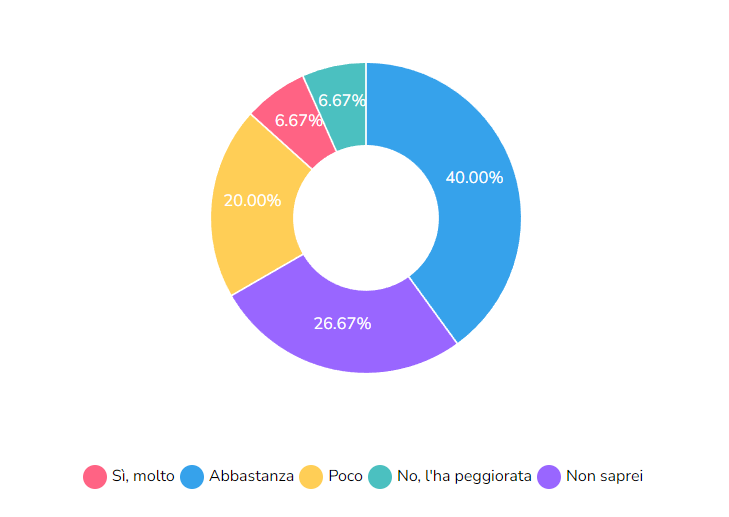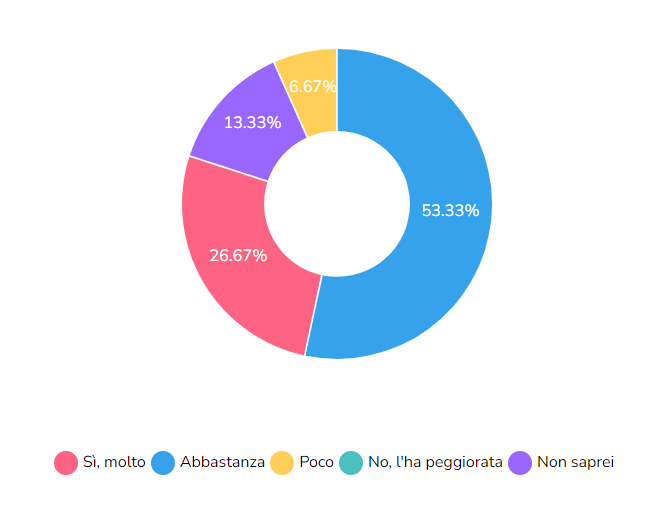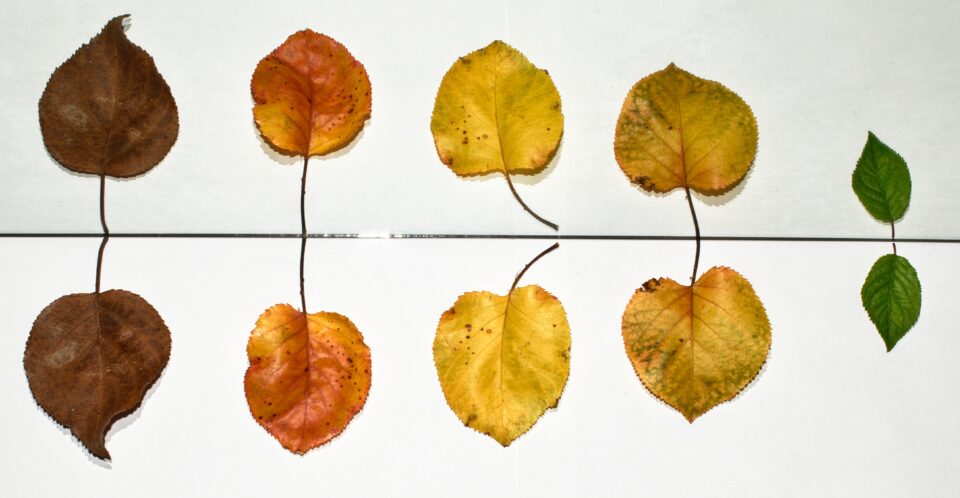Invitato dall’amico comune Carlo Ridolfi, scrivo alcuni punti per avviare un dialogo pubblico con Christian Raimo.
Appena si è diffusa la notizia della morte di Giuseppe Lenoci, il sedicenne morto durante uno strage, Raimo ha scritto sul suo profilo: “L’alternanza scuola lavoro va abolita.” Vorrei spiegare per quali ragioni ritengo che l’alternanza non vada abolita (anche se di fatto il Pcto già non è più alternanza). Sono costretto però, per evitare ogni equivoco, a fare il giro lungo, con una premessa politica e una premessa pedagogica.
a) Premessa politica
Sono figlio di un operaio, cresciuto in una delle città italiane più difficili e povere. Sono cresciuto in una casa – un basso – di due stanze. La prima faceva da cucina e camera da letto per noi figli, e conteneva anche il bagno; l’altra era la camera da letto dei miei genitori. Questo era il livello di vita che il mio paese garantiva alla famiglia di un lavoratore. Il mio status personale era corrispondente. Era, cioè, pari a zero. Ho scoperto presto che chiunque avrebbe potuto farmi qualsiasi cosa. Un docente, ad esempio, avrebbe potuto tranquillamente insultarmi, senza ragione, davanti a tutti. Nessuno avrebbe vendicato il torto subito.
Crescendo ho sviluppato una rabbia molto forte nei confronti di una società così diseguale. Rabbia che si è espressa, negli anni dell’adolescenza, con posizioni di estrema sinistra che non escludevano, in via di principio, il ricorso alla violenza per cambiare lo stato di cose. Dopo il 1989 sono approdato gradualmente, e non senza inquietudini, ad un anarchismo nonviolento o, se si preferisce, a una visione anarchica della nonviolenza. Decisivo è stato, per me, lo studio approfondito del pensiero di Aldo Capitini. Se dovessi sintetizzare in modo estremo la mia posizione politica attuale, direi questo: penso che si debba lavorare per costruire l’uguaglianza sociale combattendo l’autoritarismo e la concezione gerarchica dei rapporti sociali, con la cultura che la regge e giustifica; e ritengo che questo lavoro vada fatto nei contesti sociali concreti. Il lavoro politico, per come lo concepisco, non ha nulla a che fare con i partiti politici e con la scelta di presunti rappresentanti del popolo attraverso le elezioni.
b) Premessa pedagogica
La mia visione dell’educazione è la conseguenza di quanto detto sulla politica. L’educazione che pratichiamo nelle famiglie e nelle scuole è malata di asimmetria, e dunque di autoritarismo e di violenza. Penso che sarebbe buona cosa passare, sul piano terminologico, dalla pedagogia alla sinagogia, parola con la quale indico l’idea di un _educarsi insieme_ simmetrico, antiautoritario, centrato sulla ricerca comune dei valori. Da anni cerco insieme ad amici di lavorare ad una pedagogia antiautoritaria, critica, nonviolenta, che però non ceda ai miti facili di certa educazione naturale, come anche a quelli dell’homeschooling. L’ho fatto con la rivista Educazione Democratica, di cui sono stato direttore scientifico, e lo faccio ora come membro della Comunità di ricerca della rivista Educazione Aperta.
In sintesi: non sono un neoliberista. Ed occorre precisarlo, perché quando si assumono posizioni non allineate su temi come l’alternanza scuola-lavoro o le competenze, capita di essere accusati di esserlo.
Veniamo dunque all’alternanza. Come è noto, è stata introdotta dalla legge 107, la legge della Buona scuola di Renzi. L’impressione è che dietro l’opposizione all’alternanza da parte di molti amici che pure condividono, almeno in parte, la mia visione politica ed educativa, ci sia questo ragionamento: Renzi è un neoliberista, l’alternanza è stata introdotta da Renzi, dunque l’alternanza è una cosa neoliberista. Il mio ragionamento è stato diverso. Sono un pedagogista, e mi sono formato sulla pedagogia progressista: da Rousseau ad Illich, diciamo. Tutta la pedagogia moderna progressista considera il lavoro manuale parte essenziale del percorso formativo. Molti anni fa – era il 2006 – in un libretto, mi divertii ad immaginare una scuola improbabile. Scrivevo, tra l’altro:
La scuola che abbiamo, borghese, in fondo ancora classista, di corto respiro, è il risultato di un sistema che ha tracciato un solco profondissimo tra il mondo delle professioni intellettuali e quello delle professioni manuali. Anche l’ultimo studente liceale sa di essere migliore dell’apprendista falegname (vittima, il più delle volte, del lavoro nero e dello sfruttamento minorile). Lui, lo studente liceale, non imparerà mai a scuola a piantare un chiodo, a tagliare una lastra, a lavorare l’orto. Nella mia scuola improbabile tutti, figli di operai e figli di ingegneri, devono apprendere un’arte manuale in un laboratorio di falegnameria, di ceramica, di elettronica o altro. Non è solo per favorire una società in cui risulti ridimensionato lo iato tra professioni manuali ed intellettuali, con la stratificazione sociale che ne consegue; è anche per l’irrinunciabile valore formativo del lavoro.
Quasi venti anni dopo, di fronte ad una legge che introduceva una qualche forma di lavoro nella scuola, avrei dovuto rimangiarmi quello che avevo scritto, sostenere che no, il lavoro a scuola è una cosa priva di qualsiasi valore formativo, perché Renzi non mi piace. Mi sono chiesto invece in concreto quali cosa, come docente, mi avrebbe consentito di fare l’alternanza.
Una breve sintesi delle esperienze di alternanza nella mia scuola include un lavoro presso le residenze per anziani di Siena, durante il quale le mie studentesse (uso il femminile sovraesteso) hanno raccolto le loro storie di vita, che poi sono state trascritte e che hanno preso forma in un libro che purtroppo non è stato pubblicato. Altre studentesse sono state presso le scuole della città e della provincia, analizzando le dinamiche comunicative in un contesto educativo. Alcune sono state impegnate presso l’Unione ciechi, ed hanno lavorato a creare audiolibri per le persone non vedenti. Altre ancora le abbiamo mandate presso una associazione che pratica l’ippoterapia con le persone disabili.
L’alternanza è stata per noi anche l’occasione per sperimentare, insieme all’Indire e alla Cgil, il Service Learning. Si tratta di una pratica diffusa il tutto il mondo, anche nella sua versione sudamericana, l’Aprendizaje y Servicio Solidario. I riferimenti pedagogici sono John Dewey e Paulo Freire; ancora pedagogia progressista. Detto in breve, si tratta di questo: impegnare le studentesse in qualche attività in favore della comunità, e farlo utilizzando in modo organico lo studio disciplinare. Per fare un esempio: un liceo linguistico che organizza un corso di alfabetizzazione per migranti. Nel Service Learning si supera la chiusura della scuola al mondo esterno, che è uno dei suoi mali più evidenti, e si fa educazione civica reale: educazione all’impegno sociale.
Nel frattempo infuriava sui giornali la polemica. Il tema era, più o meno, questo: è giusto mandare gli studenti a preparare i panini al McDonald’s? Non so se davvero qualche Liceo delle Scienze Umane, qualche Liceo Classico, qualche Liceo Artistico o Scientifico o Istituto tecnico abbiano mandato le proprie studentesse a preparare i panini al McDonald’s. Se lo ha fatto, bastava chiedere conto di questa scelta educativa. E invece no: si è usato quel fatto, reale o presunto, per attaccare il nostro lavoro.
Si dirà: ma no, nessuna studentessa del Classico o dello Scientifico è mai stata mandata a fare i panini. Ci sono andate quelle del Professionale. E la questione, qui, diventa un’altra. Spero che si possa convenire però su un punto: nelle scuole non professionalizzanti l’alternanza scuola-lavoro ha permesso (parlo al passato perché, ripeto, il Pcto è un’altra cosa) di fare esperienze significative e che hanno arricchito la formazione, anche politica, degli studenti.
Veniamo dunque ai percorsi professionali. Ho insegnato in Istituti professionali prima della Buona scuola renziana. C’erano stage, ma non importava a nessuno. Tutti lo consideravano normale. In molti abbiamo letto il ben reportage di Annalisa Camilli su L’essenziale (Morire di scuola e di lavoro a 18 anni, 29 gennaio 2020) su Lorenzo Parelli, morto durante uno stage in fabbrica. Camilli ricostruisce il contesto: un paese in provincia di Udine, al centro di un distretto industriale. “I ragazzi da queste parti cominciano a lavorare presto, subito dopo il diploma, a 16 o 17 anni”, scrive. E della giovane vittima e di un suo amico, dice: “Erano contenti di lavorare, ne avevano parlato”. A un giovane che, in una zona in cui si trova facilmente lavoro appena usciti da un centro di formazione professionale, bisogna dire che no, non deve farlo; che deve andare a scuola, studiare letteratura, storia e filosofia, e rimandare il lavoro.
Io insegno Filosofia e Scienze Umane. Amo le mie discipline. Visceralmente. Penso che studiarle renda persone migliori. Ma non ho la presunzione di sentirmi migliore di nessuno, né considero persone mancate coloro che non le hanno studiate. Né, ancora, penso che la cultura passi necessariamente dalla scuola. Per dirla tutta, mi preoccupa molto anche il vuoto che spesso c’è dietro una formazione scolastica. In un contesto in cui quello che conta è il voto, la cultura diventa un mezzo, non un fine. E spesso è un mezzo che viene tolto di mezzo — mi si passi il bisticcio — appena non serve più.
Ma consideriamo l’ipotesi dell’abolizione degli stage nei percorsi professionalizzanti. Si tratterebbe di eliminare gli Istituti professionali e il Centri di formazione professionale: null’altro. Perché chiaramente non avrebbe alcun senso, in questi percorsi, fare scuola senza alcuna pratica. Che succederebbe? Semplicemente, ci sarebbe lavoro senza scuola. Chi vuole lavorare, se non ha una scuola che lo prepari al lavoro, va direttamente in azienda o in fabbrica. Lo scenario realistico, se si chiudessero tutti i percorsi professionalizzanti, non sarebbe quello di una liceizzazione generale, ma lo spostamento della formazione dalla scuola o dai centri di formazione alle aziende. E questo vuol dire una cosa concreta: vuol dire che se a scuola c’era la possibilità, tra le altre cose, di studiare anche italiano e storia, ora ci sarà _solo_ il lavoro. Si continuerà a morire — se non si lavorerà seriamente sulla sicurezza sul lavoro: perché quello è il problema. Ma mancherebbe anche altro. Perché la scuola può essere anche — non lo è, temo: ma può esserlo — il luogo in cui è possibile formare alla coscienza dei propri diritti di lavoratore. L’esperienza del lavoro, filtrata dalla scuola, può diventare consapevole e critica. Eliminare questi percorsi significa gettare nelle mani delle aziende dei lavoratori assolutamente sprovveduti, abbandonati nelle mani di un mercato del lavoro spietato, pronti alle forme peggiori di sfruttamento.
Christian Raimo
1. Io sono figlio di un operaio che in trentott’anni nella stessa azienda e diventato quadro e poi dirigente e di un’insegnante, mentre i miei nonni sono contadini, donne delle pulizie e operaie. La mia emancipazione sociale è stata tutta o quasi determinata dalla scuola pubblica e dalla università pubblica. Anche per questo per la scuola democratica pubblica, oggi sotto attacco in molti modi, è un baluardo da difendere.
2. Mi sembra che abbiamo una concezione diversa di cosa sia lavoro. Per me lavoro si può definire tale se si paga, altrimenti è volontariato, militanza, servizio, attivismo. E solo a partire da questa premessa chiaramente le nostre ispirazioni possono concordare, da Daniel Goens a John Dewey alle varie forme del socialismo e dell’anarchismo.
3. Nessuno studente è mai andato a friggere le patatine da McDonald’s. McDonald’s dal 2016 prende circa 10mila studenti in Italia e gli dà due compiti essenzialmente: gli servono da focus group e fanno promozione aziendale. Questo è molto più utile all’azienda, le permette di fare selezione a costo zero, marketing gratuito, e brandwashing, e di impedire che si sviluppi una cultura del lavoro e una coscienza di classe.
4. Io non penso che la formazione professionale non debba esserci, ma penso che debba essere il più possibile a carico delle aziende, che sono state inondate di miliardi per fare questo. Penso che la maggior parte della formazione professionale è appunto una formazione da operai, non certo da manager né su come funzionano i processi di produzione o rudimenti di economia aziendale.
5. Come si sa, la novità più significativa che vuole introdurre Patrizio Bianchi sono gli Its. Gli istituti tecnici superiori. Ossia percorsi professionalizzanti post superiori in modo da selezionare e formare, di nuovo in modo gratuito per le aziende, lavoratori adatti al mercato del lavoro territoriale, il più possibile disponibile just-in time. L’idea che fonda gli Its è che la pedagogia e la didattica la facciano scuole e aziende insieme, con la prevalenza delle aziende.
6. Il lavoro, il lavoro minorile non pagato oltre che un’ingiustizia plateale determina ovviamente un effetto di dumping, di desindacalizzazione degli altri lavoratori
Antonio Vigilante
La scuola emancipa?
“La mia emancipazione sociale è stata tutta o quasi determinata dalla scuola pubblica e dalla università pubblica. Anche per questo per la scuola democratica pubblica, oggi sotto attacco in molti modi, è un baluardo da difendere”, scrive Raimo.
La scuola che emancipa. La scuola pubblica che emancipa. Sul concetto di scuola pubblica rimando a quanto ho scritto su uno degli ultimi numeri de Gli Asini. Ritengo che la scuola italiana sia sempre meno pubblica: perché sempre più chiusa in sé stessa e sempre meno in grado di dialogare con le comunità. Che la scuola italiana non emancipi, Raimo lo sa meglio di me. Le differenze sociali in Italia sono determinanti per la riuscita scolastica. Quelli che arrivano alla laurea hanno per lo più alle spalle genitori laureati. Le percentuali di riuscita scolastica per quelli che provengono da famiglie culturalmente povere sono scarsissime.
Perché la scuola non riesce a funzionare con questi studenti? Perché il rapporto educativo funziona se c’è riconoscimento reciproco. E il riconoscimento reciproco è possibile solo se c’è riconoscimento culturale. Se la mia cultura, quella scolastica, è quella giusta, e la tua cultura – che include, poniamo, il dialetto – è quella sbagliata, un abito che devi dismettere, nessuna relazione educativa è possibile. Lo studente cui si chiede di deporre il suo abito culturale per trovarsi nudo in un ambiente ostile — perché la scuola è un ambiente umanamente freddo e ostile — semplicemente scappa via.
Ma che vuol dire poi emancipare? È emancipato il laureato in lettere costretto a una vita di contratti precari e malpagati nell’editoria o a una supplenza breve? L’Italia è un paese che ha un bassissimo numero di laureati, ai quali non riesce a dare un lavoro decente.
E che vuol dire, poi, emancipare? La vita diventa una sorta di concorso su larga scala, una specie di serie televisiva coreana con alcuni che vengono a galla mentre altri restano sul fondo. Gli emancipati e i dannati. Io vorrei che la scuola lavorasse, capitinianamente, per tutti: non per emancipare alcuni. Vorrei una scuola che lavorasse per dare dignità e valore a tutti i lavori, sia intellettuali che manuali, perché la società ha bisogno sia degli uni che degli altri. Ma una scuola solo intellettuale fa il contrario: educa tacitamente al disprezzo dell’operaio e dell’artigiano.
Cos’è lavoro?
Scrive Raimo: “Per me lavoro si può definire tale se si paga, altrimenti è volontariato, militanza, servizio, attivismo”. E in effetti gran parte delle polemiche contro l’alternanza nascono da una fallacia definitoria. Cos’è lavoro? Solo quello che si paga? Sono le sei di mattino, ho appena fatto colazione e ora sto scrivendo questa replica a Raimo. Cos’è questo? Lavoro? In un certo senso sì. Nel linguaggio comune usiamo la parola lavoro per indicare qualsiasi cosa che richieda impegno. Quando scrivo un libro, io _lavoro_, anche se i miei libri vendono cinque copie, e non ci guadagno nulla. Quindi no, che il lavoro si possa definire tale solo se si paga è concettualmente sbagliato. Anche quello che gli studenti fanno a scuola è lavoro; ed è, spesso, un lavoro durissimo.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, articolo 2, afferma che le finalità dell’alternanza sono:
1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Il lavoro, qui, è “esperienza pratica”; e la società civile conta quanto il mondo del lavoro. Ci sono tutti i margini, nella legge, per declinare l’alternanza scuola-lavoro come formazione alla cittadinanza con la metodologia del Service Learning. Per impegnare, cioè, gli studenti in percorsi di partecipazione attiva, politica, alla vita sociale, in rapporto con le associazioni del territorio. Si è preferito appiattire l’alternanza su un presunto sfruttamento, affossando una delle più grandi occasioni di formazione _politica_ dei nostri studenti.
Il MacDonald’s
Nessuno costringe nessuna scuola a mandare gli studenti al McDonald’s. I percorsi sono stabiliti dalle singole scuole. Se si ritiene che l’esperienza al McDonald’s non sia formativa, basta non mandare gli studenti. La palla è alle scuole. Ripeto: la legge consente infiniti percorsi di alternanza altamente formativi anche sul piano politico e civile. Si è preso la briga, Raimo, di documentarsi su cosa hanno fatto le scuole, nei percorsi di alternanza? Davvero vogliamo discutere di alternanza riducendola al McDonald’s?
La formazione professionale
” Io non penso che la formazione professionale non debba esserci, ma penso che debba essere il più possibile a carico delle aziende, che sono state inondate di miliardi per fare questo”, scrive Raimo. Questa è una pessima uscita. Soprattutto contraddittoria. Da un lato si afferma il valore della scuola come luogo di emancipazione, dall’altro si afferma che la formazione al lavoro dovrebbe essere sottratta alle scuole e affidata senz’altro alle aziende. Uno dei sensi profondi dell’alternanza – o degli stage – è quello di formare una cultura dei diritti del lavoratore. Per far questo, occorre che l’esperienza nel mondo del lavoro avvenga in un contesto in cui possa essere analizzata in modo critico. Lasciare alle aziende, senza alcun rapporto con la scuola, la formazione lavorativa, vuol dire lasciare loro mano libera nella formazione di lavoratori perfettamente adattati alle richieste, alle esigenze, agli abusi del mondo del lavoro.
Nell’immagine: L’officina della scuola di Barbiana. Fonte: Fondazione don Lorenzo Milani.