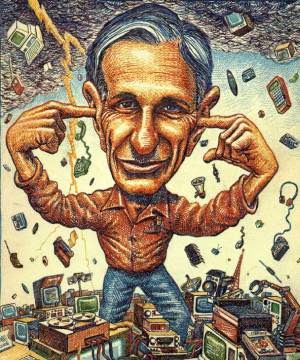Ragazzini che prendono a botte un anziano disabile a Manfredonia; altri, appena più grandi, che sulla statale 16 aggrediscono con spranghe delle ragazze rumene, una delle quali incinta. Senza pietà, senza umanità.
Sarebbe un grave errore trarre da queste notizie di cronaca – molte altre se ne potrebbero aggiungere – conclusioni generali sugli adolescenti ed i giovani di oggi. Chi come me lavora ogni giorno con i ragazzi sa che, per fortuna, ancora moltissimi ragazzi sono capaci di empatia, di rispetto, di attenzione per l’altro. E tuttavia sarebbe un errore non meno non interrogarsi su questi segnali di disumanità.
I due ragazzi arrestati per l’aggressione alle ragazze rumene hanno un profilo su Facebook. Uno dei due ha mostra il bicipite tatuato nell’immagine di copertina. Nell’immagine del profilo ha una camicia generosamente aperta sul petto che mette in mostra un grande crocifisso; occhiali enormi, come si usano adesso. In una delle foto è in posa accanto ad un cartello con una scritta in dialetto che traduce così: “Più mi guardi e più in grasso”. La sua precedente immagine di copertina, ancora visibile sul profilo, immortalava un ragazzo col cappuccio che punta una pistola. Tra le informazioni si legge: Studia presso La Cattiveria; precedentemente: La Strada e ladro.
L’altro ragazzo nella foto del profilo è in posa da pugile. Anche lui ha studiato presso la strada (questa volta con la minuscola). Sul profilo gli amici lo sostengono dopo l’arresto. Una ragazza scrive: “fai subito a uscire che dobbiamo fare altre stronzate insieme”.
Visitando questi due profili sapendo cosa hanno fatto, è facile trarre conclusioni. C’erano tutte le premesse, senza alcun dubbio. Il problema è però che quei due profili, che a posteriori appaiono come i profili di due criminali, non sono troppo diversi dai profili di tanti altri ragazzi. L’estrema cura dell’aspetto, con esiti qualche volta anche ridicoli, la palestra, i bei vestiti, le pose da duro. Dietro c’è, non è possibile non notarlo, la ricerca del personaggio: e il modello è, naturalmente, televisivo. Il duro ipercurato è un modello che a quanto pare riscuote un certo successo tra i ragazzi, quale modello umano.
Pare (non sono in grado di controllare la notizia) che uno dei due aggressori delle ragazze rumene sia vicino a CasaPound. Se fosse confermata, la notizia non stupirebbe. Il quadro umano appena delineato è ovviamente fascista, e lo è anche in mancanza di qualsiasi consapevolezza politica. E’ fascista il culto della durezza, anche quando non si traduce nell’azione vigliacca (come sempre è ogni azione fascista) contro donne o anziani, ma resta a livello di look e di posa. E’ fascista il disprezzo nei confronti dei deboli. Sono fasciste le “stronzate”, per usare il termine di quella ragazza.
C’è un humus fascista, dunque. Che va condannato, senza alcun dubbio, ma che va soprattutto compreso.
Qualche giorno fa una studentessa stava ascoltando musica in cuffia. Le ho chiesto cosa ascoltava. Mi ha detto un nome che non ho mai sentito. Poi mi sono documentato: si chiama Salmo. E’ un rapper italiano, sui trent’anni. Leggo su Wikipedia che in una sua canzone, Merda in testa, si trova un verso omofobo: “Se avessi un figlio gay sicuro lo pesterei”. Provo ad ascoltare qualcosa. Un brano si intitola “Il senso dell’odio”. Dice tra l’altro:
Non ci resta che l’odio quando tutto finisce
mi troverai ancora qui, dove il senso lo percepisce.
Non ti resta che l’odio, lui detta e io scrivo.
Fin che senti il senso dell’odio potrai dire di essere vivo!
non ci resta che l’odio…
Sia chiaro: non intendo dire che i ragazzi diventano fascisti o protofascisti perché ascoltano musica rap. Un adolescente degli anni Ottanta ascoltava Ozzy Osbourne ed AC/DC. Probabilmente musica migliore del rap di oggi, ma certo non ne traeva una visione del mondo improntata all’amore universale. La rabbia e l’odio compaiono facilmente nella psicologia adolescenziale e giovanile. Non che siano tratti naturali: gli antropologi sono lì a dimostrare che la variabilità della percezione di sé nelle culture è enorme. Ma da qualche decennio la psicologia dell’adolescente nelle società occidentali è caratterizzata da emozioni fortemente negative, spesso anche distruttive. Non è difficile individuare le ragioni di questa rabbia. Nelle nostre società ai ragazzi si nega qualsiasi partecipazione alla vita sociale. Chiusi per anni nelle scuole – luoghi poco piacevoli -, sono immersi per anni ed anni in rapporti asimmetrici. A diciott’anni uno studente a scuola deve chiedere ancora il permesso per andare in bagno, ed è fortunato se la sua aula non ha le sbarre come la cella di un carcere. Privo di qualsiasi autonomia economica, è totalmente dipendente dai suoi genitori. Gli manca il piacere di dedicarsi ad una qualsiasi attività in favore della collettività, e gli manca quel riconoscimento sociale che soltanto il lavoro è in grado di offrire.
I ragazzi vivono, dunque, una condizione di marginalità. Quello che colpisce è che, diversamente dal passato, la rabbia che scaturisce da questa marginalità non si dirige contro i genitori. Gli adolescenti di oggi considerano la famiglia un valore. Forse l’unico. La famiglia è il porto sicuro nel quale rifugiarsi. L’altro lato della medaglia è l’assoluta impoliticità. C’è una opposizione dentro/fuori. Dentro, nella famiglia, c’è tutta la sicurezza, tutta la fiducia, tutto il bene. Il fuori fa paura. E’ meglio evitare di occuparsene. Perfino gli amici possono tradire, mentre i genitori non tradiranno mai: è una idea che ho sentito mille volte dai miei studenti, e che non sarebbe mai venuta in mente ad un ragazzo degli anni Settanta o Ottanta.
C’è rabbia, dunque. Una rabbia che cerca uno sfogo, ma che non lo trova in famiglia. Dove, come sfogare la rabbia?
Ho detto che sulla statale 16 dei ventenni hanno aggredito delle ragazze rumene. I giornali hanno dato la notizia diversamente. Le ragazze diventano prostitute. Ora, la definizione non sembra errata: si tratta di ragazze che si stavano prostituendo. Ma il fatto di prostituirsi fa tout court di una ragazza una prostituta? No, se la ragazza non si prostituisce volontariamente. Una ragazza che sia costretta a prostituirsi non è una prostituta. E’ una persona vittima di violenza sessuale, ridotta in schiavitù.
Per chi le ha aggredite, erano senz’altro prostitute. E le prostitute sono da sempre disprezzate. Di qui la logica criminale da cui è scaturita quell’azione: se le ragazze rumene che stanno sulla statale 16 sono delle prostitute, e se le prostitute, per consenso unanime, sono da disprezzare, non c’è nulla di male a prenderle a sprangate.
Quello che sta succedendo è che la rabbia giovanile, che è un portato della società capitalistica, incontra una cultura del disprezzo che si sta sempre più diffondendo in seguito alla crisi economica. Quando le cose vanno male sono i più deboli a farne le spese. I veri responsabili della crisi e degli spaventosi squilibri nella distribuzione della ricchezza non perdono nulla della loro rispettabilità; pagano invece quelli che sono ai margini, quelli sui quali pesa un atavico disprezzo, che ora diventa odio e si traduce in azione.
Ecco dunque dove sfogare la rabbia. Esistono dei soggetti che, per il fatto stesso di essere ai margini della società dei consumi, sono privi di dignità umana. Corpi in vendita privi di fortuna, liberamente massacrabili. Il corpo della prostituta, il corpo del migrante, il corpo del clochard.
E’ importante che ci si indigni per l’aggressione a due ragazze, una delle quali incinta, o a un anziano. E’ un segno di umanità. Ma può essere un segno di ipocrisia, se non è inserita in una riflessione più ampia. Se non ci si è indignati anche, ad esempio, per il vergognoso accordo con il quale il governo Berlusconi, con il favore del Partito Democratico, ha consegnato i corpi e le anime, i sogni e le speranze dei migranti africani ai torturatori ed agli assassini libici. E’ ipocrisia, se si finge di non vedere la terribile violenza contro i deboli che attraversa tutta la nostra società, sostenuta da una cultura del disprezzo che si annida nelle pieghe dei discorsi pubblici e privati, nei titoli di giornale, nell’uso apparentemente innocente di termini che tolgono dignità ad un essere umano e sacralità al suo corpo.