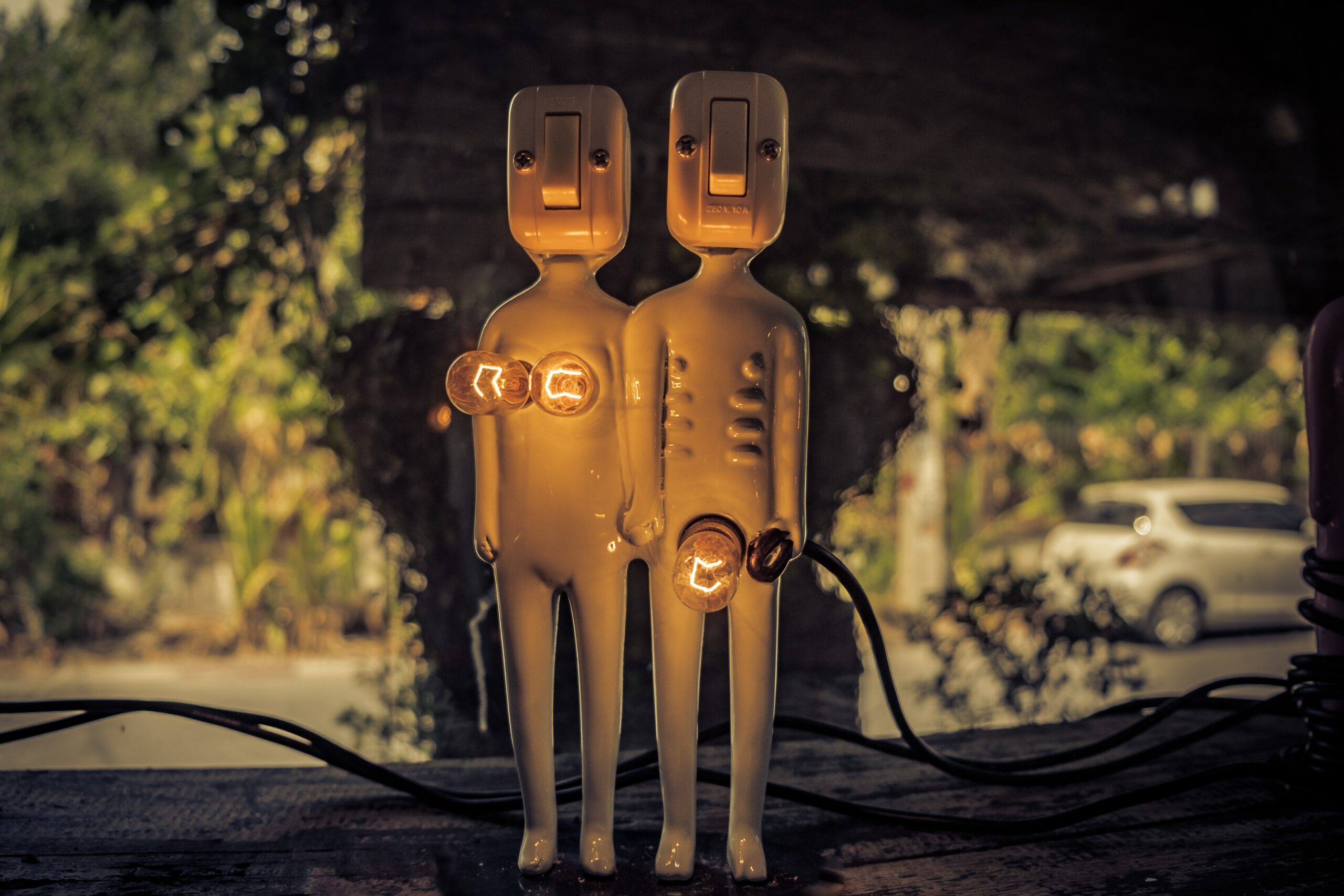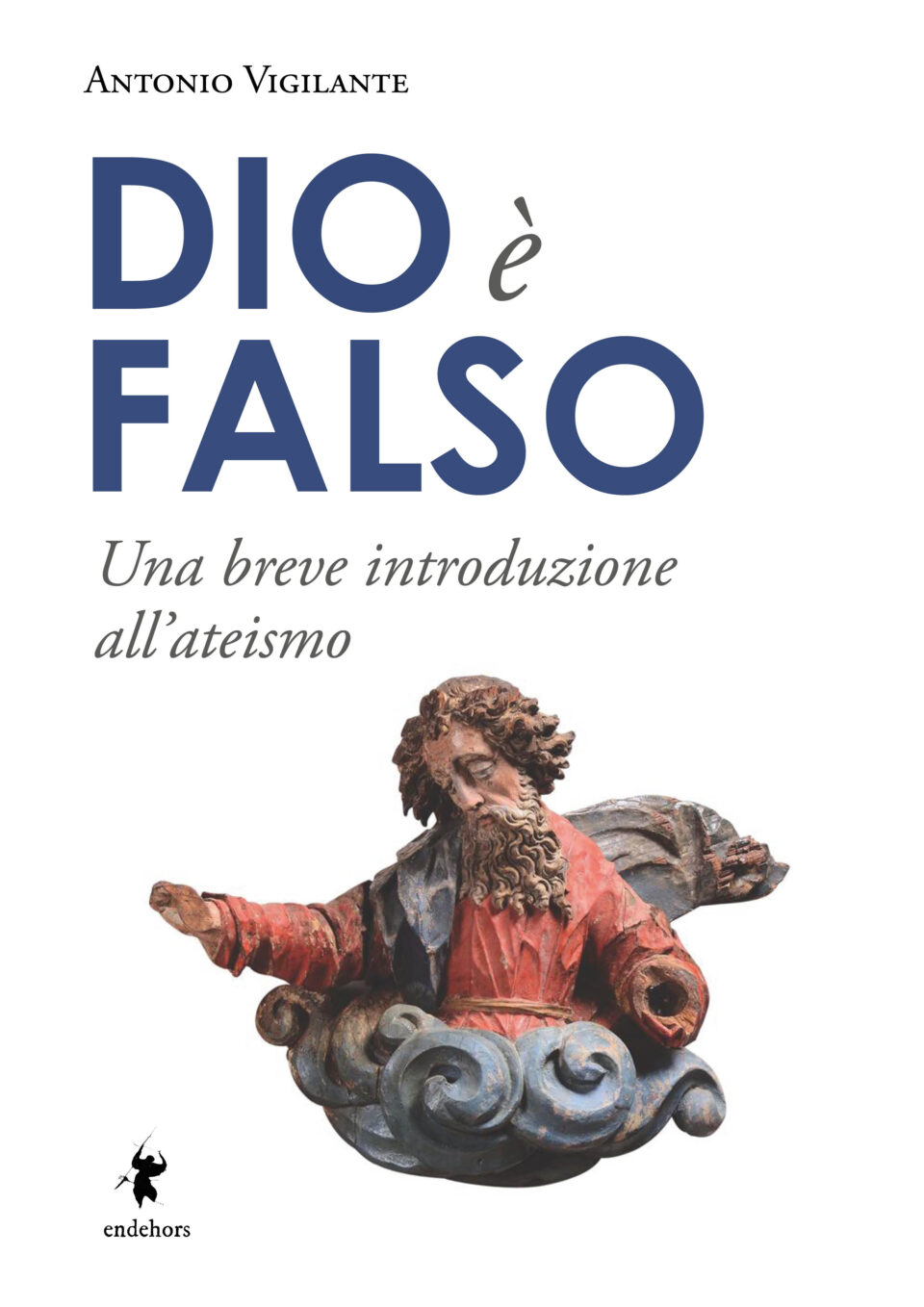Nell’enciclica Laudato si’, papa Francesco presenta una visione dell’ecologia che definisce più volte integrale. In cosa consiste l’integralità? Nel fatto che comprende le dimensioni interrelate dell’ambiente, dell’economia, della cultura, della società, considerando le conseguenze che i cambiamenti in ciascuna di queste dimensioni hanno su tutte le altre, ma non solo. L’ecologia di papa Francesco è integrale anche perché contempla tutti gli aspetti della visione del mondo cattolica. Utilizzando un termine di Raimon Panikkar, possiamo dire che l’ecologia cattolica di papa Francesco è cosmoteantrica. Se l’ecologia è la scienza dei rapporti, l’ecologia integrale di papa Francesco va intesa come la disciplina che si occupa dei rapporti tra l’essere umano, la natura e Dio. Riguardando anche Dio, una tale ecologia non potrà essere una scienza, ma dovrà risultare dal dialogo tra scienza e religione. Che rapporti ci sono tra Dio, l’essere umano e la natura? Secondo la Genesi, Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza e gli affidò il compito di dominare la terra. Il testo biblico dice, esattamente:
וַיְבָרֶךְ אֹתָם, אֱלֹהִים, וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ; וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם, וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבְכָל-חַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת עַל-הָאָרֶץ. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra e dominatela, e soggiogate i pesci del mare, gli uccelli del cielo e ogni vita che si muova sulla terra” (Genesi, 1, 28).
I verbi adoperati in questo passo sono inequivocabili. Il verbo che ho tradotto con “dominatela” è kabash, che Gesenius, autore del più autorevole dizionario dell’ebraico biblico, traduce come segue: pedibus conculcavit, pedibus subiecit, e per estensione subegit (1). Letteralmente dunque si tratta di mettersi qualcosa o qualcuno sotto i piedi. L’altro verbo, che riguarda specificamente gli animali, è radah. Gesenius traduce: (pedibus) calcavit; subegit, dominatus est (2). Sono due verbi che esprimono una grande violenza: l’essere umano ha da Dio il mandato di mettere il proprio piede sulla terra e su tutti gli esseri viventi, compresi quelli che sono in cielo. In questa violenza originaria, in questo primo mandato violento, che ha in occidente un valore fondante, pur appartenendo al mito, molti hanno visto le radici della violenza umana sulla natura. Tra i primi, lo storico della scienza Lynn White, che in un articolo pubblicato su Science nel 1967 sostenne, appunto, che la crisi ecologica ha radici cristiane. Il suo ragionamento era basato su un semplice sillogismo: la scienza e la tecnica sono nate in Occidente e poi si sono diffuse in tutto il mondo; l’occidente è cristiano; la scienza e la tecnica non esisterebbero senza il cristianesimo. “Specialmente nella sua forma occidentale – scriveva – il cristianesimo è la religione più antropocentrica che il mondo abbia mai visto” (3). Il cristianesimo distingue l’essere umano, creato a Dio a sua immagine, da tutte le altre creature, sulle quali ha il mandato di dominare e che può usare per i propri scopi. La natura non è più sacra, come nel paganesimo. E tuttavia la natura è stata creata da Dio, e dunque è una via per mettersi in contatto con lui. Se la prima teologia ha interpretato la natura simbolicamente, dal tredicesimo secolo in poi si cerca Dio nella natura studiando il suo modo di funzionare e le sue leggi. E’ così che la scienza scaturisce dalla teologia. Purtroppo, questa tecnoscienza che intendeva conoscere la natura per conoscere Dio ha finito per devastare la natura. Secondo papa Francesco si è trattato di un equivoco. Il mandato biblico non dà all’uomo alcun potere assoluto sugli animali e sulla natura, poiché la terra appartiene solo a Dio. L’essere umano è chiamato da Dio a custodirla, ad esserne non il padrone, ma l’amministratore. Scrive papa Francesco:
Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura della natura sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile (4).
Non c’è nulla di particolarmente nuovo in questa idea dell’essere umano quale “amministratore responsabile” della natura. E’ la formula individuata da quando la teologia cattolica ha cominciato ad occuparsi delle problematiche teologiche (il passo citato del resto è seguito da una nota che richiama una dichiarazione dei vescovi dell’Asia del 1993). Parole molto simili si trovano in papa Ratzinger, non particolarmente noto per le sue aperture teologiche o politiche. In un messaggio per la giornata mondiale della pace del primo gennaio del 2000, Benedetto XVI affermava che l’uomo e la donna sono stati creati “ad immagine e somiglianza del Creatore per ‘riempire la terra’ e ‘dominarla’ come ‘amministratori’ di Dio stesso (cfr Gen1, 28)” (5). E, oltre che non nuova né originale, non è nemmeno particolarmente rivoluzionaria. Si tratta di nulla più che di una sfumatura, che non muta in nulla l’aspetto fondamentale della questione: la posizione dell’uomo nel cosmo. Per White, come per altri critici del cristianesimo (compreso il cattolico Eugen Drewermann, sospeso a divinis e ridotto allo stato laicale nel 1992)(6), l’antropocentrismo è il problema culturale da cui deriva la crisi ecologica, che non potrà essere superata fino a quando non si giungerà a considerare l’essere umano come una parte della natura. Quello proposto da papa Francesco è, per così dire, un antropocentismo moderato. L’essere umano resta il centro del creato, unica creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio, ma il suo potere non va inteso come potere assoluto. Il papa rifiuta risolutamente la prospettiva del biocentrismo, perché “Non si può esigere da parte dell’essere umano un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità” (7); vale a dire: se non si riconosce la sua unicità di creatura fatta ad immagine di Dio. Papa Francesco non si limita a riaffermare l’antropocentrismo, garantito dal teocentrismo – l’essere umano è unico perché c’è Dio -, ma rilancia:
Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il modo migliore per collocare l’essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi (8).
Altrove, nell’enciclica, si legge che “non si può proporre” una relazione con l’ambiente che prescinda dalla relazione con l’altro e con Dio, perché ciò sarebbe “un individualismo romantico travestito da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi nell’immanenza”(9). Il che vuol dire che tutti coloro che non credono in Dio non possono essere autenticamente ecologisti, e che l’ateismo, sia pure religioso (ad esempio il buddhismo, che è una religione ateistica che ha molto da dire sui temi ecologici), è necessariamente violento ed antiecologico. Con questa enciclica, in sostanza, il cattolicesimo si arroga l’ecologismo. Il citato Lynn White riteneva che all’interno del cristianesimo fosse presente una sorta di antidoto alla violenza verso la natura: il francescanesimo. Francesco d’Assisi è, per lo storico americano, “il più grande radicale nella storia cristiana dai tempi di Cristo”. Egli ha istituito una sorta di democrazia tra le creature, una fratellanza che supera e cancella il dominio. Ma la rivoluzione francescana ha fallito, ed è prevalsa “l’arroganza cristiana ortodossa verso la natura” (10). Ora, papa Francesco si richiama apertamente a Francesco d’Assisi, al suo amore per la natura, alla sua fratellanza verso gli esseri non umani. Ad un certo punto, giunge a sfiorare una affermazione importantissima: quella della sacralità della vita non umana. Come è noto, per la Chiesa cattolica la sola vita umana, anche quando è ancora in embrione, è sacra; nessuna altra vita lo è. Con una formula nella quale appare evidente la sua formazione gesuitica, papa Francesco afferma:
Oggi la Chiesa non dice in maniera semplicistica che le altre creature sono completamente subordinate al bene dell’essere umano, come se non avessero un valore in sé stesse e noi potessimo disporne a piacimento (11).
Il che dovrebbe significare che gli esseri non umani hanno un valore intrinseco, se non una loro sacralità. Nella stessa enciclica, però, il papa sottolinea che il pensiero ebraico-cristiano “ha demitizzato la natura” e, senza smettere si ammirarla, “non le ha più attribuito un carattere divino” (12). E questo significa invece ribadire che l’essere umano è l’unico essere divino della natura, in quanto imago Dei, e che la vita di nessuna altra creatura è sacra. Da ciò dovrebbe scaturire una cura nei confronti del creato, fragile ed imperfetto nella sua non-divinità. Nessuna orizzontalità, dunque; nessuna reale fraternità tra le creature. Papa Francesco ribadisce la tradizionale visione cattolica del cosmo: in alto Dio; sotto Dio l’essere umano; sotto l’essere umano, la terra e le creature. Questo “essere sotto” del mondo e delle creature non è più un “essere schiacciato”, ma resta la visione gerarchica. Uno che di ecologia se ne intendeva, Murray Bookchin (tra parentesi: è il creatore dell’ecologia sociale, espressione che il papa usa senza citarlo), sosteneva l’urgenza di “estirpare l’orientamento gerarchico della nostra psiche” (13), quella disposizione mentale che ci porta a creare realtà inevitabilmente disuguali, in qualsiasi campo della nostra esperienza. La stessa opzione etico-economica per gli ultimi ed i poveri – a proposito della quale papa Francesco in questa enciclica ed altrove dice cose importanti ed assolutamente condivisibili – può restare parziale, senza una rivoluzione psichica e culturale che ci conduca a cercare ovunque relazioni orizzontali, aperte, democratiche, a rigettare la cultura dell’alto e del basso, del primo e dell’ultimo, del sacro e del profano. La crisi ecologica richiede una rivoluzione culturale, un nuovo sguardo sul mondo che re-immerga l’essere umano nella natura e che porti in primo piano, anche dal punto di vista etico, la vita non umana. Quella proposta da papa Francesco è, su questo punto (che non è marginale, ed al quale si collegano tutti gli altri temi economici, sociali, etici) una riforma, più che una rivoluzione.
Note
(1) W. Gesenius, Lexicon Manuale Hebraicum ed Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros, Vogelii, Lipsiae 1833, p. 465.
(2) Ivi, p. 924.
(3) L. Whyte, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, in Science, vol. 155, n. 3767, 10 march 1967.
(4) Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, Tipografia Vaticana, Roma 2015, p. 91.
(5) Benedetto XVI, Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la celebrazione della XLIII Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
(6) La critica di Drewermann all’antropocentrismo è in Der tödliche Fortschritt: Von der Zerstörung der Erde und des Menschen im Erbe des Christentums, Pustet, Regensburg 1981.
(7) Lettera enciclica Laudato si‘, cit., p. 93.
(8) Ivi, pp. 59-60.
(9) Ivi, p. 93.
(10) L. White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, cit.
(11) Lettera enciclica Laudato si’, cit., p. 55. (12) Ivi, p. 61.
(13) M. Bookchin, L’ecologia della libertà. Emergenza e dissoluzione della gerarchia, tr. it., Elèuthera, Milano 2010, p. 518.